Intuizioni d’artista
Nelle campagne arrivano gli aromi delle cose che abbiamo modellato con le nostre mani, rompendole nelle nostre mani,
sentendole pezzo
per
pezzo,
scomponendole nelle parti
che le hanno composte,
atomi legati ad atomi,
disfatti
e
poi
rifatti, pesanti e poi leggeri.
L’eco della voce di mio zio nelle cantine fresche di riparo dal sole cocente del Mezzogiorno a mezzogiorno, si impasta al deglutire della sua saliva, ed essa si diluisce al pomodoro fresco appena addentato,
non ho fiato.
La fragranza si distribuisce tutta quanta sul modo in cui pronuncia il mio nome, e fa così:
Giuseppe, Giuseppe, assaggia, tieni, senti quanto è dolce, vedi come è buono.
Nelle mie papille gustative di bambino, quel sapore sonoro si dilata, accettando l’incarico inconsapevolmente. La sfida di provare a tradurre e continuare una forma di vita in cui mi sarebbe piaciuto rimanere per sempre incastrato, a metà strada, tra l’affricata prepalatale sonora con cui ha avuto inizio e la prosecuzione della vibrazione nelle corde vocali di cui il mio nome si compone, riempiendosi di aria e facendo passare nella faringe gli atomi scomposti
di pomodoro e saliva,
di un ricordo e di una posa,
di un posto e di un momento preciso, di un richiamo e di un sostegno,
tutti attraverso la mia bocca, per sentire quanto è dolce ciò che per sempre si perde; per vedere, finalmente, come è buono quando ti ritrova.
Giuseppe, vieni qui, qualche volta mi ripeto, per richiamare anche quel destino che mi ha piantato in mezzo alla terra bruna martoriata dal sole come il seme di un ulivo che germoglia lentamente, e un po’ anche per fare l’eco a quegli incontri incantevoli con zio, lontani dalla frenesia della lotta per la vita, eppure così dentro la vita, che penetrano sotto il manto scuro delle zolle dissodate.
Quando spunteranno i tuoi dolci frutti,
quando potremo morderli e scomporli,
quando saremo in grado di vedere come sono buoni, e sentire quanto sono dolci?
Ho camminato come fa chi si aspetta qualcosa dal destino e poi capisce che non è vero niente, né che esiste, né che ognuno è artefice della sua fortuna. Perciò, ho iniziato il mio viaggio itinerante nella scoperta: mi sono riscoperto attore, creatore, fotografo, artista, per realizzare che in fondo il cerchio si chiude e chiuderà con me che mi rivesto da uomo e basta.

Quando ho iniziato a scattare foto, non sapevo dove mi avrebbe portato, ho guardato tutte quelle ragazze con gli occhi di chi voleva scovare qualcosa sotto il velo di Maya, e ci ho trovato un erotismo immobile. Un erotico estetico che si compagina in un processo fotografico e si proietta tutto sulle curve dei corpi calmi, scivola lungo le gambe colorate di calze lunghe e si dilata su superfici, sedie, divani, muri, e alla fine straborda come onda stanca al calar della giornata.
Appena le figure hanno cominciato ad uscire dai fianchi delle foto, sia quelle sviluppate, che quelle postate sui social, viste da così tanta gente che quasi non lo credevo possibile, ho capito che quei corpi dovevano riempire uno spazio, o svuotarlo dalla sua solitudine: così è nato vuoto. E le ragazze con le calze lunghe si sono prese per mano, prima bianche e poi nere, dapprima in trecento appoggiate sul pavimento della Peschiera di Pesaro, per moltiplicare quella condizione che ha la temporalità dell’attesa: indefinita, e talvolta infinita. Ho scattato una foto, anche se quei vuoti che abbiamo cercato di riempire con le ragazze che mi circondavano, erano carne viva, performante, teatrale.

La vita, – e cioè il teatro –, e la fotografia hanno cominciato a rifluire l’una nell’altra, mi pareva di poterne udire la melodia sorda, di quelle che senti solo dentro, e non sai nemmeno se è reale perché gli altri non se ne accorgono. Allora tu stai lì e cerchi di tradurla, affinché alla fine possano ascoltarla anche loro.
Io provavo a far rimbalzare i suoni muti attraverso le immagini, anche se prima di diventare immagini erano tante altre cose, la preparazione alle cose, l’attesa dell’atto performativo, la disposizione degli oggetti in una stanza, la ricerca di una modella da fotografare e ancora, l’attesa del momento percettivo, il “solo-dopo” cosmico che ci mette in comunicazione con le nostre sensazioni, solo dopo averle vissute, solo quando hanno già agito nel mondo, solo nel momento in cui l’onda appiattita cancella il segno, che scovato sulla sabbia bagnata, lascia una coda quasi invisibile. Ritrovarne le tracce, laddove tutto sembra un’uniforme superficie liscia, sorda e muta: questo era lo scopo della mia traduzione.
Il primo vuoto ne ha generato un altro, e così vuoto #2 ha provato a suonare le corde del buio riempiendo la Reggia di Caserta: solo 12 ragazze appoggiate su dei gradini, anziché 150 come avevo progettato. Non più oceano, ma un mare di corpi, un abisso poco profondo e il colore che ha: sfumature di nero.
Sono stato sopra e sotto il vuoto, dove si riflette la luce e dove non arriva, ché le condizioni umane oscillano sempre tra il pensiero della vita e la sensazione della morte, solo che ce la scostiamo di dosso scrollando le spalle, perché fa paura, e perché ci hanno insegnato che non bisogna averne, che la paura è un mostro da sconfiggere, che il coraggio è bianco, e il terrore è nero, che uno è la luce, come il bene, e che l’altro è buio, come il male. E invece pure il male qualche volta è luminoso, e bello, come il sangue vivo che scorga dalle ginocchia quando da piccolo scopri che puoi cadere mentre stai correndo in un giorno d’estate. Piangi perché non lo capisci, e solo-dopo lo rimpiangi perché quella cicatrice sulle ginocchia è il vessillo del tempo perduto: a furia di ripensarci, ciò che in verità era stato solo male fisico, vivo, transita nella sfera del bene, e ti fa sorridere con le lacrime appoggiate sugli occhi che non sanno cadere, e stanno in attesa del prossimo ricordo, o della prossima volta.
Nel 2019, il giorno del mio trentesimo compleanno, ho venduto la mia identità artistica: iosonopipo, non era più mio. Ma dopotutto, lo era mai stato? Iosonopipo ero io, ma non ero mio. Mi appartengo solo nella misura in cui riesco a dare, per questo ho sentito il bisogno di entrare in una relazione più diretta con le persone, e ho posato, da bravo attore, la maschera di fotografo che mi ero messo. Quello spettacolo era finito, il pubblico aveva applaudito abbastanza, e io volevo recitare a viso scoperto.
Giuseppe, vieni qui, mi ripetevo sempre più spesso, e quella cosa tra le cose, che è stato l’inizio della mia vita, mi ha richiamato nel punto in cui tutto si muove verso il centro, e imita il moto circolare uniforme della terra attorno al proprio asse, oppure delle lancette dell’orologio. Ancora una volta lo spazio e il tempo, un luogo e un momento,
e io in mezzo
a cercare di capire
cosa volesse dire.

Perché uno lo deve sempre raccontare? Non si può solo fare? Tutta questa premessa per dire chi sono ha davvero fatto capire qualcosa in più di me? Non sarebbe stato meglio presentarmi con le mani sporche di farina
dopo aver impastato orecchiette e focaccia?
La mattina non ho bisogno di sveglie, mi muovo come fanno i girasoli, seguendo la luce del sole, e nelle stanze poco illuminate ho deciso che non ci voglio vivere, ci deve essere almeno una finestrina di cui tutti prima o poi hanno bisogno se cercano un contatto con gli altri, se cercano una voce, se aspettano un’immagine o una profezia. La cosa più importante delle finestre è che prima o poi però vanno richiuse, le finestre valgono tanto proprio perché chi si affaccia deve poter scoprire una cosa nuova tra le cose, un segreto sussurrato nell’orecchio, e chi si è affacciato prima di te è tenuto a richiudersela alle spalle. La finestra deve sempre implicare il dovere dell’avvicinamento: se la trovi già spalancata ti basta girare la testa e spiare da lontano senza metterci la faccia. Ecco come si ripassa con la penna una distanza disegnata a matita.
È un po’ quello che succede a Bologna, che Bologna alla fine ha quel moto circolare uniforme che ti riporta sempre in un punto in cui affacciarti, tra finestre grandi e dentro, tra finestre più piccole. Alcune che devi lasciare per forza spalancate, altre a cui fa male affacciarsi, altre ancora che devi chiudere perché solo-dopo l’azione si compie e finisce appena ne comincia una nuova, nel processo di apertura-chiusura. Prendiamo ad esempio quella finestra piccolissima che si affaccia sul Canale delle Moline, quella performance di apertura-scoperta-chiusura-attesa, ci chiama tutti in scena, il teatro della vita si infiltra nelle piccole spaccature lasciate aperte nelle azioni quotidiane, e mentre qualcuno si avvicina a quel muro aranciato
che pare parete uniforme,
spingi con la mano
e sposti per entrare in un micro universo,
un luogo nel luogo,
solo per poco,
il tempo di guardare,
il tempo di scoprire se il canale scorre o è in secca.
Come ci rimane male chi scopre il brutto! Non gli piace quello che vede, si aspettava l’acqua e invece ha scoperto che è triste la città senza una fontana orizzontale, ci ha trovato solo un deserto arido e qualche balconcino. Si arrabbia forse, è deluso magari, e la finestra non la chiude, se ne dimentica. La magia si interrompe e i segreti sono svelati da subito. Chi passa si abitua all’apertura nel muro, e non si incanta più a scovare il sussurro che fa la città, la finestra non parla più, non ci mette in comunicazione. La reazione a catena si interrompe, e nelle aperture calano questi veli invisibili che ci allontanano e alienano. Il buio assorbe tutto, assorbe piano piano, e poi si spegne.
Un giorno è capitato così, ho deciso di spegnere il buio, e sono andato a cercare quella finestra. Intanto aspettavo per osservare come vi interagivano le persone, e i primi si dimenticavano di custodire il segreto: non la richiudevano mai. Poi ho cominciato a recitare nel teatro della vita, il palcoscenico stretto tra i tavoli del ristorante e la fila delle persone. Un passo lento e pieno, un vuoto riempito da un vuoto,
respiro incerto
nell’afa di giugno,
volto scoperto.
Mi affaccio, guardo,
faccio una pausa,
inspiro,
e sicuro richiudo.
Ritornato nel punto di osservazione, ho la conferma di aver re-innescato quella reazione a catena, perché questo mi sembra di essere: un detonatore, un bombarolo, uno che prende la miccia accesa tra le mani senza curarsi di poter esplodere da un momento all’altro, solo per posizionarla nel punto giusto, che è quello che tutti possono vedere, scoprire, e a un certo punto sentire. Maschere o etichette sono solo un battito di ciglia tra battiti di ciglia, momenti di buio, tra momenti di luce, un attore, un fotografo, un artista, io sono Giuseppe.
Io sono Giuseppe:
vieni qui Giuseppe, chiudi la finestra Giuseppe, fai entrare la luce Giuseppe, passami i pomodori Giuseppe, vieni a vedere come si impasta Giuseppe, dammi una mano Giuseppe, fammi una foto Giuseppe, leggimi questa storia Giuseppe, aspetta un altro po’ Giuseppe, cosa stai facendo Giuseppe, quanti anni hai Giuseppe? Tra quanto arriverai Giuseppe? Perché parli in questo modo Giuseppe? Vieni a vedere come si sente Giuseppe, prendilo in mano, mangialo, ascoltalo, raccontalo piano, immaginalo prima, traducilo, fallo vedere, metti i colori, cancella il vuoto, togli la luce, accendi il buio, apri la finestra, chiudi la porta, pianta quel seme,
aspetta che cresca,
aspetta che esca,
aspetta che esca,
aspetta che cresca.
Giuseppe vieni qui, facciamolo vedere a tutti gli altri che sei solo Giuseppe.
Io sono solo Giuseppe, una cosa tra le cose, un’attesa nelle attese, appoggiata, desiderante, viva, immobile, veloce, luminosa, calda, pulsante, rumorosa, silenziosa, stanca, vera.
Ho raccontato una storia, ho chiamato a raccolta qualcuno che avesse voglia di sporcarsi le mani, e ho cominciato a far vedere che sono solo Giuseppe mettendo le mani nella terra, l’inizio è faticoso e imbrattato, scotta: abbiamo seminato delle parole che cresceranno, in via Cage, a Bologna. 180 dischi di argilla dei colli bolognesi, e 26 tipi di semi. Ci siamo piegati sulla stanchezza con il sudore grondante, ché dopotutto le cose belle fanno male, e le promesse vere sono sacrificio. Ti prometto che crescerò, recita lo spazio, e nel Futuro Semplice la certezza che succederà, che prima o poi inizierà, che solo dopo crescerà, senza averne la certezza, perché la vita funziona che tu fai una cosa sapendo che finirà, o anche se potrebbe non accadere mai.
Ci vuole tempo per raccogliere i frutti, perché per fortuna qualche volta le cose succedono, e qualcuno ci prende per mano, riempie un vuoto, fa rumore, risponde alla chiamata, gira la testa, scopre un segreto, apre la finestra. Quest’azione è stata il preludio a un’altra promessa, quella del moto circolare non uniforme della vita: Il ciclo della vita. Ho piantato un altro seme raccontando ciò che ho intenzione di fare, che mi richiama al teatro della vita, al rito della vita, al rito del raccolto, all’atto del richiamo, alle mani sporche, all’inizio e alla fine, al buio e alla luce, al pieno e al vuoto. Coinvolgerò mia madre per impastare 41189 orecchiette, che rappresentano il mio Nacque, e in una residenza aperta entrerò in scena per la prima rappresent-azione. Dopo aver conosciuto un ulivo di circa due o tre anni, a settembre lo pianterò e aspetterò che cresca, per poi produrre la quantità necessaria di olio per fare una focaccia che Crebbe e che mangerò, assieme a tutti coloro che contribuiranno alla lentissima produzione, da zero. Il mio testamento prematuro mi riporterà all’inizio di tutto, inglobandolo. Infatti tra qualche anno, chiederò a mia madre di friggere una polpetta, la congelerò e prima di salutare questo tempo e questo spazio, la mangerò, perché una polpetta: Morì. Il terzo atto sarà la mia conclusione, l’ultima fotografia, lo spettacolo finale, l’azione totale.
Giuseppe, si è fatto tardi, ripeterò come mi intimava mio zio, dobbiamo andare da tua madre, e mi guarderò attorno come mi guardavo intorno allora, chiedendomi se avremmo lasciato tutto così, a metà, solo iniziato, non finito:
i canovacci sporchi, le bottiglie per la salsa ancora vuote;
i pomodori appena colti sparsi sul tavolo, la pentola per cuocere posizionata sul fornello;
le sedie apri e chiudi ripiegate a caso e appoggiate contro una parete, come in attesa della prossima volta, sospese;
l’odore acre della cantina, che pizzica un po’ il naso, ma si addolcisce con l’abitudine, come quando ti accorgi che sei diventato grande e le cose che pensavi brutte, ritornano belle;
la finestra chiusa sul nostro segreto fatto a mano, la penombra che si cerca d’estate per sfuggire al caldo, come si cercano le promesse;
il buio sfumato che assorbe i connotati del nostro volto, il colore dei vestiti, il rumore dei sospiri, il tempo e un luogo, la Puglia e un inizio, la fine e soltanto un indizio, come succede con le cose destinate ad essere dimenticate.
–Giuseppe, vieni qui!
–Ma lasciamo tutto così?
–Sì, tanto torniamo domani.
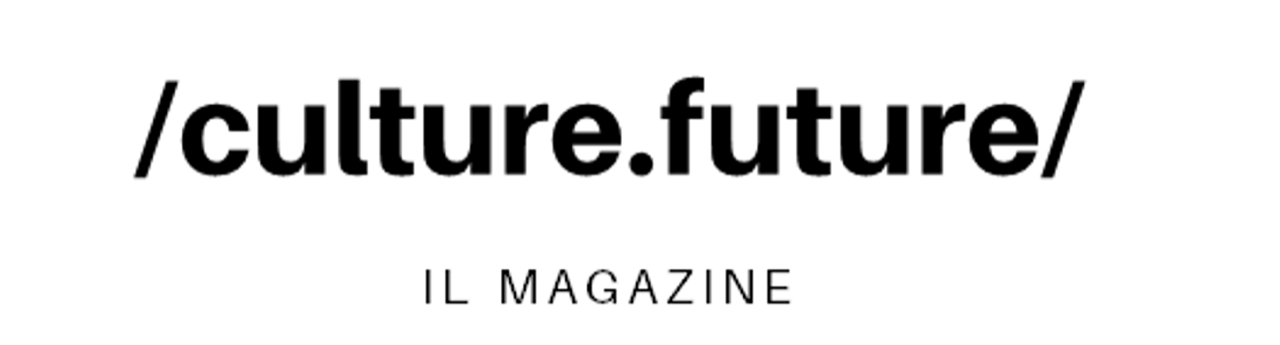








Segui i nostri profili social